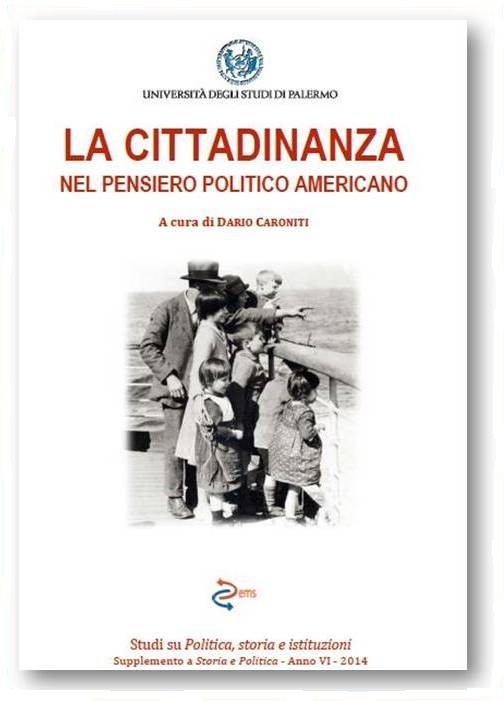Ralph Waldo Emerson.
Il
popolo di uomini e l’American idea.
1.
L’Uomo
che pensa
Negli
anni della Rivoluzione, la composizione
etnica del popolo americano che abitava le
colonie era ancora quasi del tutto omogenea.
Ad eccezione degli afroamericani, la gran
parte della popolazione era di origine
inglese o scozzese. Il distacco dalla
madrepatria non era avvenuto in virtù di una
rivendicazione di diversità di stirpe, di
lingua o di cultura, ma per una differente
concezione politica. La Dichiarazione di
indipendenza – scaturita dalla
rivendicazione del diritto storico
costituzionale alla rappresentanza (no
taxation without representation) –
l’atto costitutivo della nuova nazione
americana, il fondamento comunitario del
nuovo popolo, proclama i diritti naturali,
tra i quali il diritto alla vita, alla
libertà e alla ricerca della felicità,
uguali per tutti, base di un ordine giusto
sul quale la comunità americana si sarebbe
costituita. (Caroniti 2008: 15-34).
Nel
corso del XIX secolo, la conflittualità tra
le diverse sezioni del paese pose dei
problemi che il contrattualismo lockiano, a
quei tempi cultura politica di riferimento
della gran parte del pensiero politico
americano, stentava a risolvere. Nel momento
in una intera sezione del paese metteva
radicalmente in discussione il pactum,
il medesimo volontarismo che ne era
fondamento diventava elemento cardine della
disunione: se i popoli degli stati
decidevano a larghissima maggioranza di
rompere il contratto sociale, non ci si
poteva certo appellare a una diversa volontà
espressa vari decenni prima. Così come dei
popoli avevano liberamente deciso di unirsi,
gli stessi decidevano adesso di sciogliersi,
rimettendo in discussione lo stato federale.
A questo si aggiungeva la massiccia
emigrazione proveniente prima dall’Europa e
poi dall’Asia, che sconvolse
progressivamente la composizione etnica
degli Stati Uniti (Martin 2014: 47-76).
A
opporsi a queste spinte centrifughe
intervenne quello che Matthiessen definì il
movimento romantico americano, il
trascendentalismo (Matthiessen 1954: 3-14).
Al suo interno furono elaborate le risposte
alla crisi di crescita della comunità
americana. Grazie all’emergere di una
letteratura tipicamente americana,
sensibilmente distinta da quella inglese, si
iniziano a intravedere i tratti culturali di
una nazione a sé stante, espressamente
descritta nei suoi tratti salienti da Ralph
Waldo Emerson. La così detta «nazione di
uomini» da lui definita nel celebre discorso
del 1837 per l’inaugurazione dell’anno
accademico ad Harvard, diversa dalle altre
per le opportunità che all’interno degli
Stati Uniti gli americani godono. Questa
comunità nazionale si distinguerebbe per il
recupero della dimensione autenticamente
umana, altrimenti avvilita
dall’identificazione tra l’uomo e la
mansione da lui svolta nel mercato del
lavoro:
La
vecchia favola cela un insegnamento sempre
nuovo e sublime; che cioè c’è un Uomo,
presente in tutti i singoli uomini soltanto
parzialmente, o attraverso una facoltà; e la
favola dice anche che bisogna prendere
l’intera società per trovare l’intero uomo.
L’uomo non è né un contadino, né un
professore, né un ingegnere, ma tutte queste
cose insieme. L’uomo è prete, studioso,
statista, economista e soldato. In uno stato
diviso o sociale queste funzioni sono
distribuite tra i singoli individui ciascuno
dei quali ha per scopo l’adempimento di ciò
che gli è stato assegnato del comune lavoro,
mentre un altro lo porta a termine. La
favola sottintende che l’individuo, per
possedere se stesso, deve di tanto in tanto
allontanarsi dal suo proprio e specifico
lavoro per abbracciare tutti gli altri suoi
simili.
Nella
realtà sociale, ci dice però Emerson, questa
dimensione originaria dell’uomo si è
svuotata, ha subito una vera e propria
amputazione, che «ha trasformato l’uomo in
una cosa»:
Il
coltivatore, cioè l’Uomo inviato nei campi
per raccogliere cibo, raramente è consolato
dal pensiero dell’autentica dignità del suo
lavoro. Egli bada alle misure, al carro, ma
non vede al di là di queste cose, e affoga
nelle condizioni del contadino, invece di
serbarsi Uomo nella fattoria. L’uomo
d’affari raramente attribuisce un valore
ideale al suo lavoro, è invece trascinato
dalla routine della sua professione, e
l’anima è schiava dei dollari. Il prete
diventa una vuota forma; il legale un libro
di leggi; il meccanico una macchina; il
marinaio, la gomena di una nave (Emerson
1962: 128-129).
Recuperare l’unità originaria è il compito
dello studioso, «l’intelletto delegato alla
distribuzione di queste funzioni», «l’Uomo
che Pensa», che va però distinto sia dal
«pensatore puro», che dal «pappagallo del
pensiero altrui» (Emerson 1962: 129). Non si
tratta quindi dell’intellettuale che si
astrae dal resto della società, ma al
contrario dell’uomo che riacquista la
capacità di contemplazione dell’universo a
prescindere dalla condizione lavorativa o
economica nella quale si trova. Che riesce
ad essere «affascinato» dallo spettacolo
della natura, dal sole dal tramonto, dalla
notte e dalle stelle, perché coglie le
intime connessioni tra essa e la propria
natura:
Corre
fra la gente l’opinione che lo studioso
debba essere un recluso, un malaticcio
inadatto a qualsiasi lavoro manuale o
impegni pubblici, come un temperino per
un’ascia. Il così detto «uomo pratico»
schernisce l’uomo speculativo, quasi che
questa categoria, per il solo fatto di
speculare o di vedere, sia inadatta a
fare alcunché. Ho sentito dire che il clero
– che è sempre, in maniera più universale di
qualsiasi altra classe, il gruppo di
studiosi del proprio tempo – viene abbordato
come fossero donne; che non sente la rude,
spontanea conversazione degli uomini, ma
solo un linguaggio largamente indebolito e
affettato. Spesso viene virtualmente privato
dei suoi diritti civili, e ovviamente fa
l’avvocato difensore del proprio celibato.
Per quanto tutto ciò possa essere vero della
classe degli studiosi, tuttavia non è né
giusto né saggio. L’azione è certo un fatto
secondario per lo studioso, ma essenziale»
(Emerson 1962: 135).
2.
L’homònoia americana
Mentre
le similitudini tra l’Uomo di Emerson,
l’uomo totale di Marx o anche il superuomo
nietzschiano sono state più volte oggetto di
approfondimento (Levine, Malachuk 2011: 12,
91, 223), molto meno lo sono state quelle
con il bios theoretikòs aristotelico. Tanto
più che l’attività contemplativa descritta
da Emerson si svolge nel tempo libero da
impegni di lavoro, non impiegato ad
assolvere ai bisogni materiali. Nell’Etica
Nicomachea, Aristotele pone in stretta
relazione la «libertà dagli impegni» (la
skolè) con la felicità, l’eudaimonìa
(Aristotele: X, 1177b4). La possibilità di
impiegare parte della giornata in attività
contemplative, che non assolvono ad esigenze
legate al bisogno, ma che vengono svolte per
il proprio benessere intellettuale,
è un carattere distintivo dell’uomo maturo
(lo spoudàios), che è l’unico ad
essere veramente libero perché vive secondo
virtù:
Se la
felicità è attiva secondo virtù, è
ragionevole che lo sia secondo la più
eccellente, e questa verrà a essere la virtù
di ciò che è migliore. Quindi, o che
l’intelletto sia ciò che è ritenuto
comandare e dominare per natura e avere
nozione delle cose belle e divine, o che sia
qualcosa d’altro; o che l’intelletto stesso
sia divino, o che sia la cosa più divina che
è in noi, la sua attività secondo la virtù
propria verrà a essere la felicità perfetta.
Che è un’attività teoretica (Aristotele: X,
1177a12).
Come
scrive Christopher Lasch (Lasch 1992:
245-248), Emerson recupera aspetti
importanti del repubblicanesimo e, tra essi,
proprio il bios theoretikòs, che del
repubblicanesimo è premessa, e lo fa quando
afferma che «l’unico autentico padrone» è
l’uomo pensante, colui che di tanto in tanto
si allontana «dal suo proprio e specifico
lavoro per abbracciare tutti i suoi simili»
(Emerson 1962: 128). L’uomo di Emerson non
si riduce quindi all’homo faber
dell’illuminismo voltairiano che, grazie al
progresso, migliora indeterminatamente le
proprie condizioni fino a raggiungere la
pienezza esistenziale nella realizzazione
economica e sociale, facendo così coincidere
benessere e ricchezza (Voegelin 2004: 35 e
sg.). A fianco del successo materiale e
quasi a conclusione e coronamento di esso,
il libero impiego del tempo libero per
attività intellettuali e spirituali è,
invece, per Emerson il tratto essenziale che
caratterizza «il vero studioso», colui che
«la natura rallegra con tutte le sue serene,
ammonitrici visioni» (Emerson 1962: 129).
Il
ragionamento di Emerson non è però
finalizzato a spiegare in modo generale
l’uomo che vive secondo virtù ma, in
particolare, lo studioso americano. Figura
che assume in sé sia una dimensione
individuale che collettiva, fino a
comprendere il carattere stesso del popolo
americano:
Non è
la peggiore disgrazia non essere, nel mondo,
una unità, non essere stimato un carattere,
non fare fruttare quel peculiare frutto per
portare il quale l’uomo fu creato, ma essere
valutati, nella massa, nelle centinaia,
nelle migliaia, di persone appartenenti a un
partito, una fetta di cui facciamo parte, e
la nostra opinione pronosticata
geograficamente come il nord o il sud. No,
non così cari amici e fratelli – ti prego,
Signore, fa che non sia così di noi.
Cammineremo sui nostri piedi, lavoreremo
colle nostre sole mani, parleremo con le
nostre menti. Lo studio delle lettere non
dovrà più essere un nome per la pietà, per
il dubbio, per una sensuale clemenza. La
paura dell’uomo e l’amore per l’uomo sarà un
muro di difesa e un festone di gioia intorno
a tutto. Una nazione d’uomini, per la prima
volta, infine, esisterà, perché ciascuno
crede in sé, ispirato da quell’Anima Divina
che ispira anche tutti gli uomini (Emerson
1962: 149).
L’individualismo americano, del quale
Emerson traccia qui i caratteri, come notano
Levine e Malachuk, non ha nulla di apolitico
(Levine e Malachuk 2011: 15 e ss. ) e non
porta alla disgregazione sociale, perché è
basato sul recupero, da parte di tutti e di
ciascuno, della completa dimensione umana,
tramite l’ispirazione all’anima divina che
gli uomini accomuna:
Noi
vediamo il mondo pezzo per pezzo, come il
sole, la luna, l’animale, l’albero; ma il
tutto di cui queste cose sono parti
splendenti è l’anima. Solamente attraverso
la visione di quella Sapienza l’oroscopo
delle età può essere letto, e facendo
ricorso ai nostri pensieri migliori,
sottomettendoci a quello spirito di profezia
che è innato in ogni uomo, possiamo arrivare
a conoscere che cosa essa dica (Emerson
1991: 159).
Quanto
alla filosofia di riferimento, Emerson si
richiama espressamente a Platone, tuttavia,
come nota Flanagan, per lui «le similitudini
tra Platone e Aristotele sono più rilevanti
delle loro differenze» (Flanagan 2011: 456),
ed è proprio Aristotele, nell’Etica
Nicomachea, ad affermare che l’intelletto
(il nous) sia cosa divina rispetto
all’essere umano e che la vita secondo
l’intelletto sia «divina rispetto alla vita
umana» (Aristotele: X 1177b30). L’amore per
il proprio io noetico costituisce infatti il
vincolo che salda gli uomini in unità,
rendendo possibile la concordia spirituale
tra gli uomini, l’homonoia, che sta
alla base della philìa politike,
quell’amore della comunità politica che
mette insieme gli uomini rendendoli tra loro
amici e che è reso possibile da una storia
comune, quindi da origini comuni, ma
soprattutto da una condivisione di principi
e aspettative:
Le
città sono in stato di concordia quando
hanno le stesse idee sui loro interessi,
fanno le stesse scelte e mettono in pratica
quello che hanno deciso insieme (Aristotele:
IX 1167a26).
Anche
secondo Aristotele, per altro, questa
concordia non si raggiunge rifugiandosi in
una concezione tribale dell’esistenza, che
confinerebbe il suo io noetico nella massa o
nel partito, a prezzo di dovere rinunciare
in tutto o in parte al bios theoretikòs.
La comunità è per lui basata sull’amicizia,
e Aristotele chiarisce che i rapporti di
amicizia che si hanno con gli amici derivano
da quelli che si hanno verso se stessi
(Aristotele: IX 1166a2). È amico chi si
addolora e gioisce insieme a chi ama, perché
desidera per gli amici lo stesso bene che
però, allo stesso modo, desidera per se
stesso. La comune amicizia si fonda per
questo sulla comune affermazione del bene,
riconoscibile tramite la comune
partecipazione al nous divino
(Soressi 2004: 32). Egli così distingue tra
uomini «dabbene» e uomini «dappoco», i quali
non riescono ad essere amici, semmai
«cercano con chi passare la giornata e
fuggono se stessi» (Aristotele: IX 1166b14).
Questa
concezione dell’amicizia è condivisa da
Emerson (Lysaker 2013: 166), secondo il
quale l’America rappresenta l’opportunità di
costituire una comunità di uomini «dabbene»
nel senso aristotelico (Flanagan 2011:
456-459). Il suo «popolo di uomini» non è il
risultato di una fusione degli individui in
una unità nazionale che estenda i caratteri
genetici dell’appartenenza, fino ad
assorbire ogni identità e, con essa,
l’intelligenza o anima divina che è in ogni
singolo. Semmai la fusione, lo smelting
pot, come lo definisce Emerson, non si
colloca in un passato costituente la nazione
americana quanto nel suo destino:
L’uomo
è la più composita di tutte le creature. …
Come nel tempio di Corinto, grazie alla
fusione e alla commistione di oro e argento
e altri metalli, si creò una nuova lega, più
preziosa che mai, detta “ottone di Corinto”,
allo stesso modo nel continente - asilo di
tutte le nazioni – l’energia di irlandesi,
tedeschi, svedesi, polacchi e cosacchi e di
tutte le tribù sia europee, che africane,
che anche della Polinesia costruirà una
nuova razza, una nuova religione, un nuovo
stato, una nuova letteratura, che sarà tanto
vigorosa come quella della nuova Europa che
era venuta fuori dallo smelting pot
degli anni bui del Medio Evo o quell’altra
che era emersa dal barbarismo pelagico ed
egizio. La natura ama gli incroci (Emerson
1912: 115-116).
L’essere «asilo di tutte le nazioni»
rappresenta l’occasione storica per fare
degli Stati Uniti d’America il luogo di
incontro delle diverse razze attualmente
esistenti. Ciò non comporta alcun problema
per la comunità. Al contrario, ne è una
sorta di elemento costitutivo. Quanti sono
arrivati sulle sponde dell’Atlantico in
cerca di fortuna e di autorealizzazione sono
destinati a incontrarsi con altri uomini
provenienti da tutta Europa e dalle più
varie parti del mondo per realizzare con
essi un nuovo ethnos. È per questo
che Emerson non usa il termine melting
pot, che indica un crogiuolo di razze,
ma smelting pot, proprio per indicare
la fusione che sta per avvenire e che darà
luogo a un evento paragonabile alla nascita
della grande civiltà europea (Carter 2007:
59). Dopo la caduta dell’impero romano e le
diverse invasioni barbariche, il popolo
europeo era radicalmente mutato, fino a
raggiungere una nuova forma di unità, dalla
quale era emersa una nuova cultura, una
religione comune e una organizzazione
politica.
Seguendo questo ragionamento, si deve
dedurre che, secondo Emerson, l’evidenza
della crisi europea sia stata esemplificata
dalla riforma protestante e dalla
disgregazione dell’Europa in diversi stati
nazionali. La irreversibile corruzione del
vecchio continente è manifesta nella
sedimentazione del particolarismo,
religioso, culturale e nazionale
evidenziatosi dal XVI al XIX secolo. Sembra
invece che l’America abbia mostrato di
riuscire a superarla mediante una nuova
visione universale, che non casualmente
Emerson definisce in modo ricorrente
«cattolica».
Questa viene supportata essenzialmente da
una unione razziale, che non può quindi
tollerare alcuna divisione tra bianchi e
neri, e da una cultura che non si ponga come
mera ripetizione o anche continuazione di
una delle vecchie culture europee, ma sia in
grado di proiettarsi in una dimensione
nuova.
Anche
sul piano della religione egli è convinto
che tale fusione possa generare una nuova
appartenenza di fede. Essa deve però
superare le divisioni precedenti senza dare
adito a nuovi particolarismi: non una nuova
chiesa, ma il recupero della cattolicità,
senza pontefici, cardinali e vescovi, grazie
alla responsabilizzazione individuale e
all’altissima valorizzazione dell’Uomo
(Birdsall 1959: 274).
L’elemento cardine sul quale ruotano le
aspettative emersoniane sta nelle
particolari opportunità che si presentano al
popolo americano e che finiscono per
accomunarlo, nonostante le diverse
provenienze e le intrinseche individualità
che lo compongono. Tra essi una peculiare
occasione storica è data dalla diffusa
alfabetizzazione, dovuta alla comune
abitudine alla lettura della Bibbia, alla
quale accede la gran parte della
popolazione. Essa compensa, nella visione di
Emerson, la mancanza dei grandi picchi
intellettuali che caratterizzavano invece la
cultura europea, e costituisce anche il
carattere identitario, democratico nella sua
essenza, non necessariamente colto ma
informato e quindi consapevole del popolo
americano, che ha reso possibile la fiducia
in se stessi, che fa credere «nel proprio
pensiero, credere che ciò che è vero per
noi, nella nostra vita interiore, è vero per
tutti» (Emerson 1962: 37).
La
comune appartenenza a un vastissimo ceto
medio - Emerson definisce espressamente gli
Stati Uniti «questo paese di ceti medi»
(Emerson 1962: 202) - non prevede
contrapposizioni di interessi e di culture.
L’America non è un posto in cui la borghesia
abbia prevalso sulle altre classi, ma dove
si è realizzata una sostanziale convergenza
tra quanti hanno voluto sviluppare la
propria personalità in modo indipendente,
trovando che tale maturazione li ha spinti
poi a legarsi intimamente raggiunta con le
particolari opportunità fornite dal
territorio, dalle istituzioni, dalle
credenze religiose e dalla società. Gli
Stati Uniti sono quindi un luogo fisico,
culturale e politico che consente all’uomo
che, in quanto uomo, è sempre «dabbene», di
cogliere le opportunità della propria
maturazione. Non sono meramente la nazione
dei self made men. Nel suo elogio
funebre del presidente Abramo Lincoln, egli
dice:
Il
Presidente fu ai nostri occhi come un uomo
del popolo. Egli fu interamente americano,
non attraversò mai il mare, non fu mai
corrotto dall’insularismo inglese o dalla
dissipazione francese; fu un autentico
indigeno, un uomo della sua terra, come la
ghianda lo è di una quercia; non scimmiottò
gli stranieri, non compì frivolezze: uomo
del Kentucky, lavorò in una fattoria, fu
battelliere, capitano nella guerra contro
Black Hawk, avvocato di campagna, deputato
nella legislatura per la legge rurale
nell’Illinois (Emerson 1962: 199).
Qui si
può anche cogliere il contrasto tra le umili
origini e il successo, tipico dell’uomo che
si fa da sé, ma l’aspetto di maggiore
interesse è la poliedricità di Lincoln, che
non cessa di essere lavoratore in una
fattoria, capitano dell’esercito e avvocato
di campagna, anche quando viene eletto
deputato e poi Presidente della repubblica.
È in questo senso che egli appartiene al
ceto medio, perché la sua elezione non è il
frutto di una scalata sociale, ed è
esattamente per questo che Emerson lo
considera il vero presidente della nazione
americana.
L’armonia del popolo americano non dipende
dall’unione di stirpe, credo e cultura. Il
massiccio arrivo di immigranti irlandesi non
deve quindi in alcun modo spaventare
l’ordine della comunità, così come
l’emancipazione dei neri è da leggere come
una opportunità di crescita e il Proclama
dell’emancipazione come «un atto poetico e
memorabile» (Emerson 1962: 191), avendo
esteso, anche a chi prima l’aveva negata, la
libertà di potere conformare la propria
anima a quella divina, ribadendo i principi
sui quali la nazione americana si fonda. L’american
idea, basata sulla più estesa forma di
dignità che possa consentire a chi è
cittadino americano di vivere pienamente la
propria esistenza, portando al massimo le
proprie potenzialità, diventa così l’homònoia
americana.
3.
L’unità indissolubile della comunità
politica americana
Il
trascendentalismo si basa su una idea
altissima di uomo, che estende le sue
potenzialità fino a raggiungere la volta
celeste (Emerson 1904: 10). La filosofia che
lo ispira si richiama a Victor, la cui
influenza sul trascendentalismo, come nota
Robert Sattelmeyer, non è mai stata
sufficientemente analizzata e valutata
(Sattelmeyer, 2014, p. 22; Joyaux 1955:
117-130). Questi aveva teorizzato che le
capacità cognitive dell’uomo si fondassero
sulla sua capacità di fare in vita
l’esperienza del divino: l’uomo conosce il
mondo perché vede il suo creatore (Cousin
1861: 33 e ss.). La beatitudine, la capacità
di contemplare Dio, non è quindi riservata
alla vita ultraterrena, ma è la base della
stessa conoscenza:
(Gesù
Cristo) ha visto con gli occhi aperti il
mistero dell’anima. Attirato dalla sua
severa armonia, rapito dalla sua bellezza,
visse in essa, in essa fu. Egli solo in
tutta la storia ha stimato la nobiltà
dell’uomo. Un solo uomo fu fedele a ciò che
è in voi e in me. Vide che Dio incarna se
stesso nell’uomo, e sempre di nuovo procede
a prendere possesso del suo Mondo. Egli
disse nel giubilo della sublime emozione:
«Io sono divino, Attraverso me, Dio agisce;
attraverso me parla. Se vuoi vedere Dio,
guardami; o guardati, quando anche tu pensi
come io penso adesso» (Emerson 1991: 101).
Partendo da queste premesse il
trascendentalismo ipotizza la realizzazione
di un ordine politico che doni all’uomo non
solo la possibilità di concepire queste
altezze ma di realizzarle concretamente
nella sua vita terrena. Non lo fa però
immaginando una rivoluzione che alteri il
corso della storia, ma allineandosi a un
percorso storico già tracciato dalla
Provvidenza, che ha riservato agli americani
questa immensa ma anche concreta
opportunità. Il progressista americano
dell’Ottocento non è quindi politicamente un
rivoluzionario, perché ritiene che le
istituzioni del paese e la sua costituzione
rappresentino la struttura di questa
eccezionale condizione, tanto da consentire
l’affermazione più che di un «io posso», di
un «noi possiamo» (Ledeen 2000: 58-59).
L’opportunità non è però riservata solo a
chi è nato in America. Essere americano è
una condizione di arrivo, non
necessariamente di partenza.
La
nazione di uomini di Emerson è composta da
chi vuole essere uomo, quindi non solo da
chi è di origine inglese e neppure europea.
L’America è il luogo ideale nel quale tutti
gli uomini provenienti da ogni parte del
mondo possono realmente raggiungere la
pienezza della loro esistenza. È per questo
che egli respinge in toto l’attacco
degli stati del Sud a quello che egli
considera un fantastico idillio: l’Unione,
per lui, non è soltanto un patto volontario
ma è provvidenziale, è la stessa essenza
dell’unico popolo americano (Myerson 2000:
71). La diatriba se a sottoscrivere la
costituzione - We the people of the
United States – fosse stato i popoli o
il popolo degli Stati Uniti viene quindi da
Emerson e dagli altri trascendentalisti
risolta senza appello nel senso di una unità
indissolubile. Emerson condanna lo
schiavismo come del tutto estraneo a una
cultura che si basa sulle uguali opportunità
di partenza (Emerson 2006: 74-76) e,
soprattutto, nega più che il diritto la
stessa possibilità che una parte del popolo
americano possa abbandonare l’Unione, perché
atto che al tempo stesso rifiuto
dell’appartenenza nazionale e delle
magnifiche sorti ad esso destinate dalla
storia. I sudisti debbono così essere
indotti, loro malgrado, con la forza, con la
guerra, a rimanere, nel loro stesso
interesse, parte dell’unica nazione che
possa dare agli uomini l’opportunità di
essere compiutamente tali:
Il
fine di ogni battaglia politica è stabilire
la moralità come fondamento di tutta la
legislazione. Il suo vero fine non sono le
libere istituzioni, né la repubblica e
neppure la democrazia, che ne sono invece i
mezzi. La morale è l’oggetto del governo.
Noi vogliamo uno stato di cose in cui il
crimine non paghi. Questa è la nostra
consolazione per l’oscurità del futuro e le
afflizioni odierne, che il governo del mondo
sia morale e distrugga per sempre ciò che
non lo è (Emerson 2007: 545).
L’individualismo emersoniano si differenzia
profondamente non solo da quello degli
agrari del Sud, ma più in generale da
Jefferson e da molti dei padri fondatori. Lo
spazio di indipendenza dell’individuo stesso
è per lui circoscritto dalla grande anima
della natura (Bloom 1994: 44).
L’affermazione dell’intelligenza individuale
come parte dell’intelligenza divina
restringe di fatto la gamma di scelte
morali, nonostante Emerson escluda
categoricamente ogni forma di conformismo o
di scolastica (Emerson 1904: 15). Quando nel
suo saggio del 1844 sulla Politica
egli scrive che «bisogna confidare con
decisione nella benefica necessità che
brilla attraverso tutte le leggi» afferma
espressamente l’esistenza di una
intelligenza comune. Egli è perciò convinto
che la natura umana si esprima nelle leggi
«come nelle statue, nelle canzoni o nelle
ferrovie», tanto che «un estratto dei codici
delle nazioni sarebbe una trascrizione della
coscienza comune». L’ordine politico ha
quindi la propria origine «nell’identità
morale degli uomini», questo perché ciò che
è razionale per un individuo lo è
necessariamente per ogni altro:
La
ragione per uno è da considerare come la
ragione per un altro e per ogni altro.
Esiste una misura di mezzo che soddisfa
tutte le parti, per quanto esse siano varie
e determinate a loro stesse. Ogni uomo
trova un canone per i suoi più semplici
diritti e atti nelle decisioni del suo
proprio intelletto, che egli chiama Verità e
Santità. In queste decisioni tutti i
cittadini trovano un perfetto consenso e
soltanto in esse. Non in ciò che è buono da
mangiare, bello da mettere o da usare, né
nell’ammontare di terra o di aiuto pubblico
che ognuno pretende di affermare come
diritto. Tali verità e giustizie gli uomini
si sforzano di applicarle alla misurazione
della terra, al porzionamento dei servizi,
alla protezione della vita e della
proprietà. I loro primi sforzi sono
senz’altro molto maldestri. Tuttavia il
diritto assoluto è il primo governatore,
altrimenti ogni governo diventerebbe una
sorta di teocrazia impura. L’idea da cui
ogni comunità è mossa per fare e migliorare
le proprie leggi è la volontà dell’uomo
saggio. Quest’uomo tuttavia non si può
trovare così nella natura, tanto che si
fanno sforzi maldestri, per quanto seri, di
assicurare il suo governo per convenzione,
come si fa attribuendo all’intero popolo la
facoltà di essere ascoltato per ogni singola
misura, o quando da una duplice opzione si
giunge alla rappresentanza dell’intero,
oppure quando si attua la selezione dei
cittadini migliori, o anche quando si
vogliono assicurare i vantaggi o le
efficienze e la pace interna affidandosi al
governo di qualcuno, che possa poi scegliere
da solo i propri collaboratori. Tutte le
forme di governo simbolizzano un governo
immortale, comune a ogni dinastia e
indipendente dai numeri, perfetto sia dove
vi sono due uomini che dove ve ne sia uno
solo (Emerson 1910: 103).
Come
per Platone, la saggezza si trova nel
filosofo, che è saggio proprio perché ama la
verità e conforma la sua anima (la psiuké)
all’ordine della virtù. Allo stesso modo,
Emerson indica l’uomo saggio quale
riferimento politico di una comunità. La
saggezza, per altro, tende alla riduzione
all’unità, ed egli ritiene che la dote di
uomo saggio o vero Uomo, in grado di
secondare le proprie scelte secondo libertà
e verità, sia una condizione molto rara
(Emerson 1904: 17).
Una società per essere giusta non può quindi
contare sul coinvolgimento diretto dell’Uomo
saggio, quanto tuttavia, come nelle Leggi
di Platone, sulla saggezza dell’uomo. La
direzione politica non va quindi
necessariamente collocata nel migliore tra
gli uomini, ma in chi riesca a ispirarsi
alla saggezza espressa dagli uomini
migliori. La conseguenza del ragionamento
di Emerson è che non sia necessaria la
monarchia né l’aristocrazia per garantire un
ordine giusto, ma si possono realizzare
delle condizioni, come quella degli Stati
Uniti, in cui la libera partecipazione
democratica del popolo sia possibile e
auspicabile, giusto perché la saggezza
dell’uomo è iscritta nel codice genetico del
popolo, e il governo migliore è quello che
governa meno e che trova come «antidoto al
suo abuso» la pubblica influenza del
«carattere privato», lo «sviluppo
dell’elemento individuale» (Emerson 1910:
104).
In
ogni caso, la storia dell’America è per
Emerson il fondamento dell’aspettativa della
nascita di un popolo di uomini la cui
esistenza è proiettata verso un futuro di
progresso e di ottimismo.
Del resto, non si potrebbe comprendere come
possa essere possibile raggiungere una
concordia in proiezione universale se non si
presupponesse una convergenza tra le diverse
intelligenze verso l’attrazione dei
migliori:
La
ricerca dei grandi uomini è il sogno della
gioventù e la più seria occupazione della
virilità. Noi viaggiamo in paesi stranieri
per trovare le loro opere – e, se è
possibile, per intravederli. Ma noi siamo
invece abbandonati dalla fortuna. Voi dite:
- gli Inglesi sono pratici; i tedeschi sono
ospitali; a Valenza il clima è delizioso; e
nelle colline; e nelle colline di Sacramento
vi è l’oro a portata di mano. – Sì, ma io
non viaggio per trovare popoli
confortables, ricchi e ospitali, o un
cielo limpido, o delle verghe d’oro che
costano troppo. Ma se vi fosse una calamita
che si dirigesse verso i paesi e le case
dove abitano le persone che sono
intrinsecamente ricche e potenti, venderei
tutto per comperarla, e mi metterei oggi
stesso in cammino (Emerson 1904: 2).
È
proprio la possibilità di ottenere una
concordia convergente verso il
raggiungimento di un vertice etico e morale,
incarnato dalle grandi figure di Uomo, che
rende inconcepibile il tentativo di dividere
l’Unione: l’armonia della comunità americana
è fondata su principi condivisi; la
secessione rappresenta una opposizione a
tali principi, alla loro universalità:
La
guerra era tremenda, ma non poteva essere
evitata. La guerra era ed è un immenso
errore, ma portò con sé l’immenso beneficio
di tirare una linea e schierare i liberi
stati su di essa fissandone la sua
insormontabilità (Emerson 1962: 196).
Ammettere la divisione degli Stati Uniti in
popoli diversi avrebbe comportato di per sé
il crollo di tutti i presupposti cardine
della comunità insieme allo stesso
individualismo, che si fonda sì sulla
eccezionale «importanza data al singolo», ma
pure sul rispetto sacrale dell’altro da sé,
esemplificato da Emerson nel rapporto che
intercorre tra stati sovrani. L’importanza
data al singolo è per lui protetta e
alimentata circondando l’individuo «con le
barriere del rispetto naturale» (Emerson
1962: 147).
4.
La fiducia e il progresso
L’esercizio della sovranità popolare ha
quindi per Emerson dei limiti precisi
dettati dalla «verità e dalla giustizia» e
intellegibili dall’individuo. Le particolari
condizioni geografiche, storiche, religiose
e antropologiche hanno reso possibile agli
individui americani convergere
collettivamente su tali principi, tuttavia
l’eventuale inosservanza di essi
comporterebbe di per sé la rivoluzione
dell’ordine stesso e sarebbe un atto di
ribellione, anche se fosse condiviso dalla
maggioranza del popolo o di una porzione
geografica di esso.
L’estensione del suffragio elettorale alle
donne, ai neri e a tutti gli immigrati
assimilabili al popolo degli Stati Uniti è
possibile per Emerson in quanto ogni
individuo è capace di abbracciare e fare
propri i principi universali sui quali si
regge la democrazia americana. Essa non
presuppone però in alcun modo
l’affermazione del diritto di voto quale
diritto inalienabile. Non si troverà quindi
in Emerson nessuna indignazione per il
ritardo col quale venne restituita agli
uomini del Sud la facoltà di scegliere la
propria rappresentanza. Essi l’avevano
sprecata approvando la secessione, a
differenza delle persone di origine
straniera che, nel raggiungere
volontariamente gli Stati Uniti, ne avevano
condiviso l’ordine politico, strutturalmente
universale. Allo stesso modo ai neri non
poteva certo essere negato il diritto di
concorrere alla rappresentanza, visto che
essi sono a pieno diritto parte del popolo
americano e lo stesso può dirsi delle donne
che, per lui, spesso posseggono «superiori
capacità amministrative», come affermò nel
1855 alla Convenzione per i diritti della
donna (Emerson 2010: vol. II 28).
Tutti
gli uomini, indipendentemente dal sesso e
dalla razza hanno «il diritto di avere
fiducia» e di «essere amati». La fiducia si
può perdere per un certo periodo, come nel
caso degli uomini che hanno votato la
secessione, ma una società repressiva è
decisamente lontana dalla visione di
Emerson, il quale pone a «fondamento dello
stato» il «potere dell’amore». Egli ci dice
che esso «non è mai stato sperimentato»:
Non
c’è dubbio che le strade potranno essere
costruite, le lettere consegnate e il frutto
del lavoro retribuito anche quando si porrà
fine al governo basato sulla forza. Sono
forse i nostri attuali metodi così
eccellenti che non ci può essere con essi
concorrenza? Non potrebbe una nazione di
amici raggiungere risultati migliori?
L’alternativa sarebbe cadere nel più bieco
conservatorismo e nelle paura, con una
prematura resa alla baionetta e al sistema
della forza. Perché, secondo l’ordine della
natura, che è decisamente superiore alla
nostra volontà, le cose stanno così: ci sarà
sempre un governo della forza quando gli
uomini saranno egoisti, ma quando essi
saranno abbastanza puri da mettere da parte
il codice della forza, essi diventeranno
sufficientemente saggi dal notare come si
possano trovare soluzioni ai problemi degli
uffici postali, dei trasporti, dei commerci,
dei trasferimenti di proprietà, dei musei,
delle biblioteche e delle istituzioni delle
arti e delle scienze.(Emerson 1910:
105-106).
La
società deve quindi fondarsi sulla philìa
politikè o, meglio, sui principi della
filosofia classica, che Emerson considera la
base della repubblica americana e della sua
democrazia. Essi quindi costituiscono il
fondamento comune da riconoscere per essere
parte del popolo degli Stati Uniti. Per
farli propri basta, se fosse cosa di facile
accessibilità, essere uomini secondo gli
elevati canoni dettati da Emerson. Ciò a
prescindere dalla razza di provenienza.
L’aspetto innovativo, quasi rivoluzionario,
sta nell’utilizzare gli strumenti del
pensiero di Platone e Aristotele per
scardinare ogni forma di conservatorismo
politico e di autoritarismo. L’affermazione
di principi etici oggettivi e permanenti è
tuttavia tutt’altro che negata, anche se non
trova conferma nelle sedimentazioni storiche
di una tradizione, quanto nella ragione e
nella saggezza dell’Uomo: è questa saggezza
che, dice Emerson, scardina le strutture di
oppressione e di sfruttamento insieme alla
paura e all’ignoranza che le ha generate.